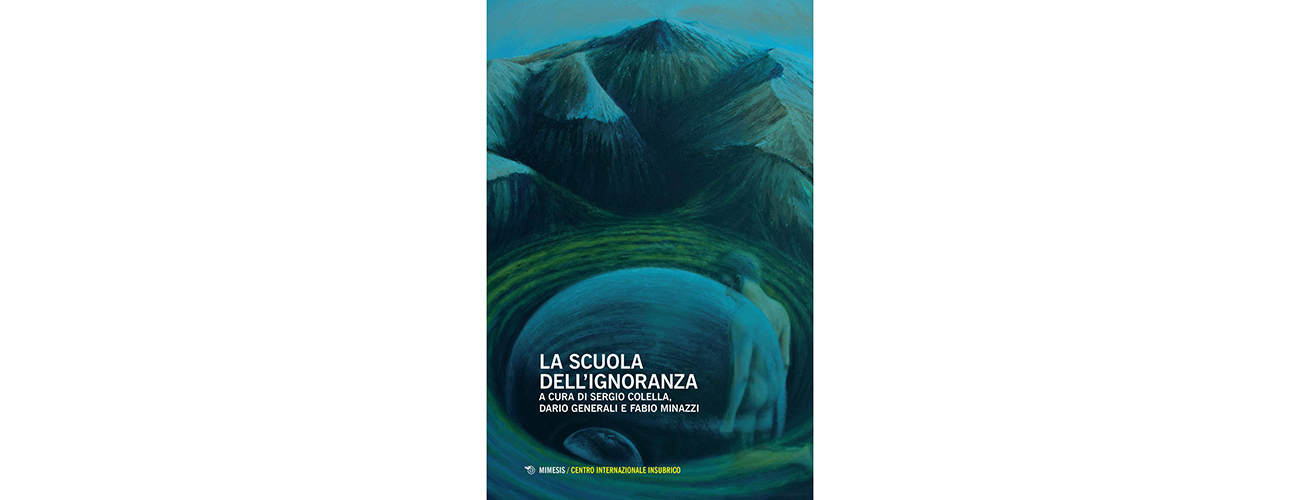
“La scuola dell’ignoranza”, a cura di Sergio Colella, Dario Generali e Fabio Minazzi, pagine 288, euro 24, Mimesis-Centro Internazionale Insubrico.
Uno dei temi che principalmente informano i contributi al volume collettivo “La scuola dell’ignoranza” è la constatazione e il dissenso nei confronti della “riduzione dei contenuti” – che si vuole evidenziare come caratteristica delle riforme del sistema scolastico promosse da Lugi Berlinger prima e dalla sciagurata gestione Gelmini poi – e la promozione, di converso, della “didattica per competenze”, approccio all’insegnamento che declinerebbe in modo eccessivo la didattica sul “fare” a discapito del “conoscere”; sostituendo, quindi, “istruzione” ed “educazione” con “formazione”. La scuola post autonomia si definirebbe come agenzia che rinuncia alla crescita cognitiva per agire sui comportamenti e sulla personalità, insomma, una scuola che rischia di condizionare invece di insegnare.
Di fatto e in sintesi, “La scuola dell’ignoranza” è un duro attacco al cognitivismo/comportamentismo che informa tutti i contributi, nei quali si lamenta la perdita delle radici culturali classiche e illuministiche a fronte di una contaminazione con la pedagogia anglosassone, che trasformerebbe le scuole in ‘progettifici’ che propongono decine di percorsi educativi (salute, alimentazione, prevenzione, educazione stradale, ecc.) a scapito dell’insegnamento delle discipline; una scuola in cui è “sovrastimata l’importanza del metodo” (G. Carosotti pag. 152), che introduce concetti come quello di “unità minima di apprendimento”, rinunciando alla selezione per merito in nome della salvaguardia delle statistiche sulla dispersione e sul successo formativo.
Per quanto siano robuste le argomentazioni, non tutto quadra; possiamo veramente buttar via la migliore pedagogia del ‘900, Dewey, Freinet, Freire (per citare solo alcuni nomi), per affidare la consistenza e la qualità della trasmissione del sapere alla capacità del docente (magari “innata”), al suo “carisma” – al sapere che affascina – come sostiene Massimo Recalcati (“L’Ora di lezione” Einaudi 2014)? Probabilmente ha ragione E. Amatulli quando sostiene che la “percezione (…) è che qualsiasi riforma senza ingenti investimenti è destinata all’insuccesso, al fallimento, e la 107 non è da meno: come ci si può illudere di promuovere inversioni di rotta a costo zero? (…) Si sono cambiati i linguaggi, ma la scuola non si è sostanzialmente modificata, si rigenera identica a se stessa, svuotando o appiattendo ogni assunzione linguistica” (pag. 220); e forse ha ragione anche Asor Rosa, citato da G. Carosotti, quando dice che “nemmeno Bottai e il fascismo riuscirono a cambiare l’istituzione scuola” (pag. 152).
Certamente le riforme quadro definiscono un’epistemologia, un progetto (fosse anche destrutturante) ma, senza investimenti, nel corpo vivo dell’istituzione non penetrano. Quel che più pesa e andrebbe considerato, anche più delle pedagogie e delle ideologie sottese alle riforme, è piuttosto il pesante disinvestimento economico-finanziario sul fronte istruzione/educazione/formazione; questa considerazione richiama un’ulteriore domanda che attraversa il testo, con risposte talvolta diverse: se la “scuola del XXI secolo” è una scuola che accentua le differenze di classe, se si è passati ad un sistema che tende a spostare sul privato la “domanda” di istruzione qualificata, relegando il servizio pubblico a servizio assistenzialistico e “di cura”. Ed è ancora sull’asse finanziario che troviamo la risposta: si può certamente dibattere di metodologie e modelli organizzativi, ma rimane sempre determinante quanto le società investono concretamente nei sistemi scolastici. In assenza di strumenti e personale adeguato in numero e qualità, qualsiasi pedagogia non può che fallire nei suoi obiettivi. Il grosso problema rimane quello degli investimenti che, tra le altre cose, depauperando la scuola pubblica favorisce di certo i flussi verso il privato.
Tirando le somme, come ricorda T. Tussi, “la questione del ‘come fare scuola’ per combattere l’ignoranza e le disuguaglianze sociali resta ancora in piedi” (pag. 114).
“La scuola dell’ignoranza” è indubbiamente un importante contributo critico che ci conduce e costringe a dover definire possibili scenari: tra la distopia di Norberto Bottani (“Requiem per la scuola?”, Il Mulino 2013) per il quale perfino la didattica a distanza si prefigura come possibile “destino” liquido per l’istruzione, e l’utopia della scuola diffusa di Paolo Mottana (“La città educante”, Asterios 2017), ovvero una scuola post-fordista che esce dalla scuola/fabbrica per diluirsi nel territorio, esiste una diversa opzione che non sia la “restaurazione” di un sistema scolastico in continuità con l’impianto gentiliano? Possiamo evitare che la scuola “che un tempo era l’avamposto del futuro” si debba considerare “oggi (…) poco più di una trincea che lotta per non finire nel passato?” (A. Panico pag. 228).



