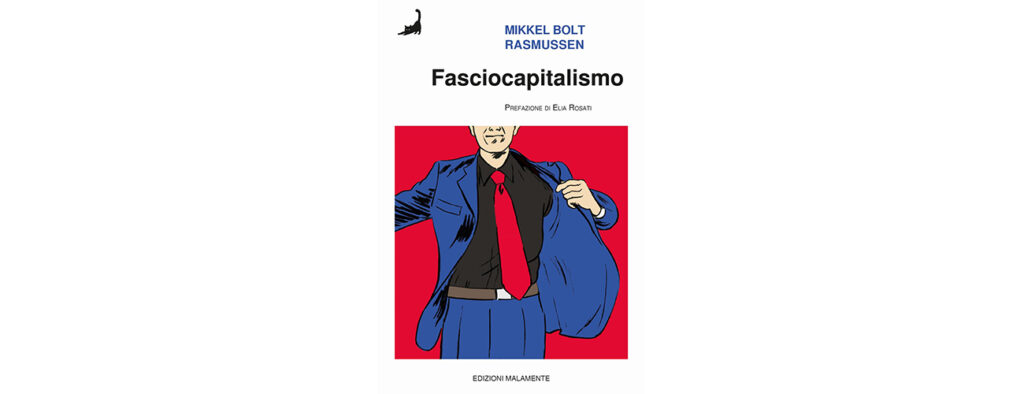
Mikkel Bolt Rasmussen, Fasciocapitalismo, Edizioni Malamente, pagine 116, euro 12.
Si concentra sulle cause che hanno permesso il riemergere del fascismo su scala planetaria l’agile ma denso e illuminante libro di Mikkel Bolt Rasmussen “Fasciocapitalismo”, recentemente tradotto e pubblicato dalle Edizioni Malamente, con una prefazione dello storico Elia Rosati, che legge il successo di Giorgia Meloni nel settembre 2022 come la “rivincita della politica come professione” di una formazione all’antica, Fratelli d’Italia, in netta antitesi con l’ubriacatura dei partiti leggeri o solo personali.
L’edizione del libro in lingua originale risale al 2021, ma le riflessioni di Rasmussen, docente di Estetica Politica all’Università di Copenaghen, sono quanto mai attuali, poiché è un cinquantennio della storia politica, sociale e culturale al centro di un’analisi che ha il pregio di legare le tendenze dell’accumulazione capitalistica con quelle della formazione dell’immaginario collettivo, sulla scorta dei contributi teorici, da un lato, di Ernest Mandel e, dall’altro, di alcuni autori della Scuola di Francoforte (Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, Max Horkeimer).
Rasmussen premette che sarebbe un errore pensare che il fascismo sia scomparso nel dopoguerra con la sconfitta dei regimi nazi-fascisti: esso ha continuato ad esistere nelle forme di “zone fasciste” nel mondo post-coloniale delle prigioni, nel razzismo nei confronti degli afro-americani, nelle deportazioni dei migranti e nei decreti “anti-terrorismo” istituiti da George W. Bush sulla base dello “stato d’eccezione” imperialista, che ha legittimato, come a Guantanamo, la privazione di ogni status legale alle persone sospette di terrorismo.
Dopo questa incredibile sequela di “lenta violenza” il fascismo tardo-capitalista è riesploso perché, con la rottura del compromesso di classe fordista nel nord del mondo, è successivamente proseguita la lotta di classe unilaterale condotta dal capitale per quattro decenni, a fronte di organizzazioni sindacali sempre più sulla difensiva, visto che la devastante delocalizzazione di molte produzioni nelle semi-periferie o periferie del mondo ha contribuito in buona parte al tramonto di una certa composizione di classe del movimento operaio. Al contempo, anche lo stato sociale è stato destrutturato da una ondata di privatizzazioni dettate dall’agenda neoliberale, con il consenso supino delle formazioni dell’ex-sinistra.
Non che questa nuova fase del dispotismo del capitale abbia risolto le ricorrenti contraddizioni intrinseche al modo di produzione capitalistico. Anzi, la loro persistenza si è materializzata nella crisi finanziaria del 2006-08, in seguito al moltiplicarsi delle insolvenze generate dai mutui subprime, nonché per l’inevitabile sommatoria di crisi da sovraccumulazione e crisi da sovrapproduzione. In quel contesto fu lo Stato a farsi carico delle ingenti perdite del sistema bancario, mentre si acuivano le diseguaglianze economiche e sociali dei cosiddetti “perdenti” della globalizzazione, in ragione anche della crescita della disoccupazione.
Qualche resistenza significativa sul piano delle mobilitazioni popolari si è manifestata nel decennio successivo in Spagna, in Francia e in Grecia, ma l’isolamento internazionale ha costretto anche una forza emergente come Syriza a capitolare sotto il maglio delle politiche dell’austerità imposte dalla Troika.
Quindi, paradossalmente, è stato il discorso xenofobo e nazionalista delle destre a crescere sul piano dei consensi elettorali, poiché, non solo sul piano della propaganda, si è dimostrato abile nell’incanalare la frustrazione e il risentimento delle classi popolari di fronte al loro declassamento sociale e soprattutto all’assenza di un futuro per le nuove generazioni, che vivono la loro precarietà lavorativa in termini di precarietà esistenziale.
In questo senso l’invenzione di un nemico esterno – i migranti – si è rivelata l’arma vincente per fomentare nuove discriminazioni e negare alle fondamenta i principi dell’eguaglianza e della solidarietà, rilanciando altresì un odioso suprematismo bianco.
Infine, a proposito delle guerre culturali che le formazioni di estrema destra hanno scatenato su ogni tematica del discorso politico e sociale – basti pensare alle reiterate provocazioni dell’anarco-liberista Javier Milei – sono molto interessanti gli approfondimenti che Rasmussen dedica al fascismo online. Infatti, a suo parere, i social media hanno qualità “congenitamente fasciste”, in quanto amplificano ulteriormente l’atomizzazione dei soggetti che vengono “risocializzati” come una folla rancorosa e aggressiva, sostanzialmente figlia di una disperazione dagli esiti tragicamente nichilistici. Perciò non sorprende come determinate tesi alimentino quotidianamente un nuovo senso comune, dato che le grandi piattaforme digitali si prestano alla costante diffusione di luoghi comuni razzisti, negazionisti, misogini, antifemministi e anti-Lgbtq+.



