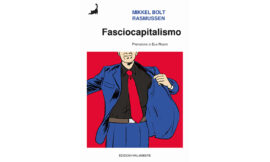Seconda parte. Per la prima parte: https://www.sinistrasindacale.it/2025/04/13/la-strage-di-brescia-sappiamo-chi-e-stato-dino-greco/
Dalla piazza alla fabbrica e viceversa: la città in mano agli operai
Poi, la seconda fase. Il processo che si determina è biunivoco e transitivo: dalla piazza insanguinata alla fabbrica e poi di nuovo alla piazza e quindi a tutta la città, governata, presidiata dai Consigli. Sono migliaia i delegati che presidiano ogni via d’accesso alla città, ogni piazza. Alla strage caratterizzata dal più alto tasso di politicità possibile si oppone ora una risposta altrettanto politica.
I due quotidiani bresciani colgono che si respira, nei giorni che vanno dall’eccidio ai funerali, un’atmosfera “rivoluzionaria”, paragonabile solo ai giorni della Liberazione, dove vigilanza, disciplina, controllo del territorio sono rimessi nelle mani di migliaia di operai, di delegati con bracciale rosso al braccio che costruiscono un nuovo “ordito” democratico.
I funerali: “Giù le mani dai nostri morti!”
I funerali sono stabiliti per il 31 maggio, a quattro giorni dall’attentato. Presidenza della Repubblica e presidenza del Consiglio vogliono i funerali di Stato e fanno pressione sui sindacati nazionali affinché se ne rispetti il cerimoniale, solo con interventi istituzionali. Luciano Lama chiama la Camera del Lavoro di Brescia e propone che in una data successiva alla cerimonia ufficiale se ne svolga una sindacale. La richiesta è seccamente respinta: i morti sono nostri, la bomba è contro di noi. Se insistono, noi non faremo i funerali di Stato. La condizione è che fra gli oratori ci sia proprio Luciano Lama: prendere o lasciare!
Il 31 maggio arriva a Brescia più di mezzo milione di persone. Le due piazze e le vie adiacenti a Piazza della Loggia sono gremite all’inverosimile. Striscioni dei consigli di fabbrica e bandiere rosse ovunque. Tutta la gestione organizzativa e la sicurezza sono nelle mani del sindacato. Né il presidente della Repubblica, né le autorità locali sono in grado di opporsi: le forze dell’ordine sono relegate nel cortile della prefettura e nelle caserme.
La contestazione alle autorità
La Brescia ufficiale, custode dei poteri istituzionali, ancora non capisce. Non capisce il decano di tutti i sindaci d’Italia, rimasto in carica per quasi vent’anni, dai giorni successivi alla Liberazione, che nel discorso pronunciato ai funerali cercherà – subissato dai fischi – di derubricare la strage a fatto locale, gesto folle di isolati. Non capisce il vescovo di Brescia, monsignor Morstabilini, che nell’omelia non saprà andare oltre un’invettiva contro lo “spirito di Caino”. Capisce ancor meno il presidente della Repubblica, Giovanni Leone, impietrito di fronte alla piazza che lo contestava dopo avere tentato di ottenere una revisione edulcorata dei discorsi ben altrimenti espliciti degli altri oratori. Capisce perfettamente il presidente del Consiglio, Mariano Rumor, che rinuncia a parlare.
Il corteo funebre percorre per tre chilometri e mezzo le strade cittadine, dalla piazza al cimitero Vantiniano, fra folte ali di folla. Il selciato è totalmente coperto di fiori, si intravede appena l’asfalto sottostante.
Un nuovo “ordito” democratico, una nuova legalità costituzionale
Ormai si era aperta una vera e propria frattura: alla delegittimazione di poteri istituzionali privi di credibilità corrisponde l’affermazione di un movimento di massa che rivendica e pratica una nuova legalità costituzionale. Quel sedimento, estesamente penetrato nella coscienza collettiva, è durato. Il ‘74 diventa, a Brescia, il mito propulsore di una nuova fase dei rapporti sociali, di un rilancio delle istanze di rinnovamento sociale e politico radicale che ispirarono le lotte del ’68-’69. Si verificherà negli anni successivi – come ricordò Claudio Sabattini – un doppio movimento che imporrà un mutamento dei rapporti di forza, tanto in fabbrica quanto tra cittadini e istituzioni. Prende corpo, in quegli anni, la breve ma intensa esperienza dei Consigli di zona, il più ambizioso tentativo operaio di proiettare all’esterno della fabbrica, nel territorio, nella società civile, la carica egualitaria di rinnovamento e di partecipazione che aveva innervato le lotte di fabbrica e attratto a sé forze intellettuali e strati sociali prima diversamente dislocati. Infine in quella temperie poté forgiarsi una leva di quadri di estrazione operaia che segnerà a lungo la storia eccentrica quanto feconda del sindacalismo bresciano.
“Sappiamo chi è Stato”
Come sappiamo, tutto questo non è stato sufficiente a Brescia – come prima a Milano e poi a Bologna – a sanzionare giuridicamente i mandanti dello stragismo nero, i protagonisti della strategia della tensione. C’è però una verità politica e storica che nessuna acrobazia, nessun depistaggio può cancellare. Il giudizio politico e la stessa ricostruzione degli eventi, della trama che li preparò, sono stati già ampiamente conseguiti, sin da quando, il primo giugno del ’74, in piazza della Loggia comparve per la prima volta lo striscione che portava scritto “Sappiamo chi è STATO”.
Le inchieste, i processi, fra omissioni e depistaggi
La catena processuale dura ormai da 50 anni. Da subito si mise in moto la catena di depistaggi, di manomissione delle prove. Siamo nell’epoca delle “larghe intese”, della “solidarietà nazionale”, che a Brescia ha radici profonde. E c’è un teorema politico che guida l’indagine giudiziaria: bisogna circoscrivere il campo delle responsabilità, da limitare ai fascisti locali, del tutto privi di legami esterni. Così recintata, la prima inchiesta dei sostituti procuratori Vino e Trovato porterà, nel luglio del ’79, alla condanna all’ergastolo del mitomane Ermanno Buzzi e di Angelino Papa, personaggi in bilico fra criminalità comune e neo-fascismo. Tutti gli altri imputati, anch’essi appartenenti alle organizzazioni del fascismo bresciano, verranno assolti per insufficienza di prove o con formula piena. Penseranno Mario Tuti e Pierluigi Concutelli, uomini di Avanguardia nazionale, a “giustiziare” Ermanno Buzzi tappandogli la bocca per sempre nel carcere di Verona.
Sarà la Corte d’assise d’appello, nel marzo dell’82, a dimostrare l’infondatezza della precedente sentenza e ad assolvere tutti.
La Cassazione annulla la sentenza e dispone che si rifaccia il processo: nuovi imputati (compaiono fra questi anche il comandante dei carabinieri Delfino e Pino Rauti), ma identico esito. Tutti assolti.
La Cassazione annulla anche questa sentenza e si torna a chiedere che si ricominci da capo. Ma anche tutte le successive sentenze, nei vari livelli di giudizio (’89, ’93, 2010, 2012) portano allo stesso punto morto.
La Cassazione stabilisce che un nuovo processo dovrà accertare le responsabilità di due degli imputati che nei processi di primo e secondo grado erano stati assolti: Maurizio Tramonte, un uomo vicino ai servizi, che tanto ha parlato negli anni di eversione e di bombe, e Carlo Maria Maggi, ottantenne medico veneziano, all’epoca a capo di Ordine Nuovo nel Veneto. Nel 2015, quarantun’anni dopo la strage, si conclude l’iter processuale con la condanna all’ergastolo di Maggi e Tramonte, confermata dalla Cassazione il 20 giugno 2017.
Buio sui mandanti: la durissima requisitoria del giudice Zorzi
Buio totale sui mandanti, sui depistaggi e sulle complicità istituzionali. Sarà il giudice istruttore Zorzi a denunciare l’esistenza di un meccanismo “che fa letteralmente venire i brividi, soprattutto di rabbia, in quanto è la riprova, se mai ve ne fosse bisogno, dell’esistenza e costante operatività di una rete di protezione pronta a scattare in qualunque momento e in qualunque luogo”.
Nelle motivazioni della sentenza si possono leggere queste drammatiche parole, sufficienti a spiegare quali forze si sono mosse per nascondere la verità sotto una colata di cemento: “Lo studio dello sterminato numero di atti che compongono il fascicolo dibattimentale porta ad affermare che anche questo processo, come altri in materia di stragi, è emblematico dell’opera sotterranea portata avanti con pervicacia da quel coacervo di forze individuabili con certezza in una parte non irrilevante degli apparati di sicurezza dello Stato, nelle centrali occulte di potere che hanno prima incoraggiato e supportato lo sviluppo dei progetti eversivi della destra estrema e hanno sviato, poi, l’intervento della magistratura, di fatto rendendo impossibile la ricostruzione dell’intera rete di responsabilità. Il risultato è stato devastante per la dignità stessa dello Stato e della sua irrinunciabile funzione di tutela delle istituzioni democratiche …”.
In tutte le stragi si è vista l’alacre attività di depistaggio degli apparati dello Stato. A Brescia si parlò di “pista libica”, poi si sostenne che la bomba fosse rivolta non già contro i manifestanti, ma contro le forze di polizia che di solito stazionavano nel luogo dove esplose l’ordigno; infine si cercò incredibilmente di attribuire l’attentato ad Euplo Natali, il pensionato ed ex partigiano perito nell’esplosione!
La strage di Brescia: una fase (e una modalità) della lotta di classe in Italia
Le stragi nere – e in modo esemplare quella di Brescia – sono state una fase (e una modalità) della lotta di classe in Italia. Una fase nella quale le classi dominanti e parte cospicua del loro personale politico hanno usato il fascismo e il terrore per impedire una profonda trasformazione dei rapporti sociali in Italia.
I conti mancati con il fascismo e il “sovversivismo” delle classi dominanti
C’è un’altra riflessione da fare: nel nostro Paese i conti con il fascismo non sono mai stati fatti e la stessa promulgazione della Costituzione, sortita dalla lotta di Liberazione, è stata vissuta come una parentesi dalle classi dominanti, il cui latente sovversivismo è pronto a riemergere ogniqualvolta la situazione lo richieda.