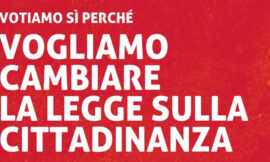Il 3 aprile scorso il Tribunale dei minori di Brescia ha condannato a trent’anni Marco Toffaloni, cittadino svizzero oggi 67enne, per essere stato uno degli esecutori materiali della strage di piazza della Loggia del 28 maggio 1974. La decisione ha accolto la richiesta del pubblico ministero. L’imputato all’epoca dei fatti non aveva ancora compiuto 17 anni. Sulla strage di Brescia pubblichiamo la prima parte di una ricostruzione storica di Dino Greco. La seconda parte nel prossimo numero.
L’antefatto della strage di piazza della Loggia: le lotte di classe a Brescia nei primi anni settanta.
Per capire cosa sia stata la strage di piazza della Loggia a Brescia del 28 maggio 1974, è indispensabile fare un passo indietro di alcuni anni. Anni cruciali che hanno rappresentato uno spartiacque nella storia dell’Italia repubblicana, lungo il decennio che va dalla fine degli anni sessanta a buona parte dei settanta del secolo scorso.
Il 20 maggio 1970 entra in vigore lo Statuto dei diritti dei lavoratori. E’ una vera rivoluzione perché, per la prima volta dalla fondazione della Repubblica, la Costituzione varca le stanze chiuse di ogni luogo di lavoro. La fabbrica non è più una zona franca, dominio esclusivo del padrone. Si riconosce e formalizza in modo cogente che i lavoratori hanno il diritto di organizzarsi e di tutelare i propri interessi in forma conflittuale, l’attività antisindacale viene punita in quanto reato, i licenziamenti di cui sia dimostrata l’illegittimità vengono revocati, la tutela dell’integrità psico-fisica dei prestatori d’opera viene con forza affermata. Da universo ‘concentrazionario’ dove è possibile ogni arbitrio padronale, la fabbrica diventa luogo dove in forza di legge è possibile affermare i diritti di cittadinanza, la libertà di pensiero, di attività sindacale.
Ma lo Statuto non piove dal cielo, è il frutto di una straordinaria stagione di lotte operaie che conquistano sul campo parte rilevante dei risultati che ora trovano una legittimazione legislativa.
Il contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici del 21 dicembre 1969, firmato dopo oltre 180 ore di sciopero, viene vissuto dai vertici confindustriali come uno smacco insopportabile. Ma il movimento operaio che era stato protagonista di quella impetuosa stagione non si ferma. E realizza forme inedite di rappresentanza sindacale, che prevedono un intreccio di democrazia diretta e democrazia delegata e rimodellano lo stesso rapporto fra sindacato esterno e rappresentanza interna.
Nascono i consigli di fabbrica. I delegati non sono più di nomina esterna ma vengono eletti da tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti al sindacato. Ogni reparto o gruppo omogeneo diventa una sorta di collegio uninominale, dove ognuno è elettore ed eleggibile. Vige la revoca del mandato, se sottoscritta dal 50%+1 dei lavoratori di cui il delegato è espressione.
Ciò che rende questa esperienza un unicum nella storia del sindacalismo mondiale è la decisione del sindacato di mettere in capo ai delegati liberamente eletti i poteri che lo Statuto attribuiva alle Rsa di designazione sindacale. Prima nei metalmeccanici, in seguito anche nelle altre categorie, i consigli di fabbrica diventano il primo livello unitario della struttura sindacale, a cui si riconoscono poteri di contrattazione e di rappresentanza. Questa potente iniezione di democrazia, che sorge direttamente dalla base, diventa l’elemento propulsore di una capillare vertenzialità mai vista in precedenza.
I padroni non mandano giù il rospo, e ogni vertenza produce uno scontro di grande durezza. Prima ancora di guadagnare il tavolo di trattativa, occorre fare riconoscere come interlocutori del negoziato i consigli di fabbrica. Davanti ai cancelli si consumano veri e propri corpo a corpo, con i crumiri e con i fascisti che appaiono sempre più frequentemente sulla scena, sistematicamente spalleggiati dalla polizia e dai carabinieri. Non solo, ormai, davanti alle fabbriche metalmeccaniche, ma anche davanti a quelle tessili, dell’abbigliamento e calzaturiere, dove sono le donne a guidare e sostenere le battaglie più dure.
I padroni non ci stanno: “Bisogna fermarli. A qualsiasi costo”.
I padroni bresciani si riorganizzano, si moltiplicano le riunioni di associazione nelle quali manifestano tutta la propria rabbia per quella che chiamano un’usurpazione, una violazione della proprietà privata, la fabbrica divenuta teatro di un conflitto di potere quotidiano. Un sentimento si fa strada sempre più acuto nel padronato: “Bisogna fermarli. A qualsiasi costo”.
Torna a galla “il marcio di Salò”, la parte più intrisa di fascismo, strutturalmente ostile al sindacato, abituata a trattare con il bastone i rapporti sociali. Giorgio Almirante viene sistematicamente a Brescia: a Nave, a Lumezzane, sul Garda, si incontra con gruppi di imprenditori, soprattutto siderurgici, garantendo loro sostegno attivo. Vengono assunte squadre di picchiatori fascisti (all’Idra di Pasotti, alla Fenotti &Comini, alla Palazzoli), con il solo compito di intimidire i lavoratori.
I prodromi della strage.
Dal 1970 in avanti è un crescente stillicidio di attentati alle sedi sindacali, del Pci e dello Psiup; si moltiplicano gli agguati a militanti di sinistra, militanti del movimento studentesco vengono aggrediti da gruppi di fascisti che fanno capo ad Ordine Nuovo.
Inutilmente il Comitato Unitario Provinciale Antifascista (Cupa) interviene presso prefetto e questore per chiedere un’azione nei confronti di organizzazioni di cui si conoscono perfettamente nomi e intenzioni. E’ sempre più chiaro che i fascisti contano simpatie, e connivenze quando non aperto sostegno, negli organi istituzionali e di polizia. Dieci giorni prima della strage un fascista, Silvio Ferrari, salta in aria con il suo scooter mentre trasporta un ordigno destinato ad un attentato.
28 maggio 1974: la strage.
Nei giorni immediatamente successivi viene proclamata dal Cupa una manifestazione antifascista a cui il sindacato aderisce unitariamente, proclamando per quel giorno uno sciopero generale di quattro ore che si svolge sotto una pioggia battente.
Alle 10,12, mentre è in corso il comizio, sotto il portico adiacente alla piazza esplode la bomba: alla fine saranno otto i morti e 108 i feriti. Muoiono sei insegnanti, l’intero gruppo dirigente della Cgil scuola che si era dato appuntamento nei pressi del cestino dei rifiuti dove era stato deposto l’ordigno, per discutere di una iniziativa per sostenere la gratuità dei libri di testo. Muoiono dilaniati anche due operai e un pensionato, ex partigiano.
Di tutti gli eccidi perpetrati nel corso della strategia della tensione, quello di Brescia è il più direttamente rivolto contro i lavoratori. Questa volta non viene scelto un luogo neutro (una banca, un treno, una stazione) dove sparare nel mucchio per creare terrore. L’obiettivo è esplicito e diretto: il nemico è il movimento operaio.
Lo sconvolgimento è totale, sangue ovunque, scene di disperazione, ma non prevale il panico. La piazza non viene abbandonata. Si prestano i primi soccorsi ai feriti. Solo due ore dopo lo scoppio, il vicequestore e il capitano del nucleo investigativo dei carabinieri procedono al lavaggio della piazza, facendo scomparire reperti essenziali per comprendere la natura dell’esplosivo utilizzato dagli attentatori: è il primo di una lunga serie di depistaggi messi in atto dagli apparati dello Stato.
La prima risposta: occupare le fabbriche e assemblee ovunque.
Immediatamente si decide di andare in massa alla Camera del Lavoro, che da quel momento diventerà lo “stato maggiore” che dirigerà per tutti i giorni a seguire la risposta operaia e popolare: una sorta di agorà nella quale partecipazione spontanea e organizzazione troveranno una sintesi perfetta.
La prima, fondamentale decisione è quella di prolungare fino a tutto il giorno dopo lo sciopero, rientrare nelle fabbriche, occuparle e svolgervi assemblee aperte a cittadini, partiti democratici, studenti. Anche il movimento studentesco bresciano decide l’occupazione di tutti gli istituti medi superiori.
L’obiettivo è quello di tenere assieme i lavoratori, impedire che prevalga lo scoraggiamento e, nel contempo, produrre un’analisi lucida della situazione e farlo nel corpo vivo del movimento.
Si organizzano centinaia di assemblee in tutte le grandi e medie fabbriche, dove confluiscono i lavoratori delle piccole aziende. E’ un popolo intero che si mette in moto. Saranno due giorni di impressionante tensione emotiva, nei quali migliaia di lavoratori e lavoratrici prendono parola. Se si sfogliano le centinaia di verbali redatti nel corso delle assemblee, non si può non essere colpiti dalla istintiva percezione che con sicuro istinto politico corre da fabbrica a fabbrica, da persona a persona: l’attentato è contro di noi, contro ognuno di noi, contro quello che siamo e che stiamo facendo. Ci sono i fascisti, certo, ma i mandanti stanno altrove: i padroni, i servizi, gli apparati dello Stato, il potere costituito.
La democrazia di massa si organizza.
Dopo un primo, breve momento di smarrimento, si genera una situazione totalmente nuova, imprevista e opposta a quella immaginata dagli ideatori della strage: al senso di paura, all’orrore e allo sbigottimento, subentra la mobilitazione. E’ la democrazia di massa che si organizza: la fabbrica, il luogo del conflitto sociale, ne diventa l’epicentro. E’ lì che ciò che potrebbe disperdersi si riaggrega, istantaneamente. Attraverso la discussione si ricostruisce l’intelligenza dei fatti, si analizza, si decide, si elabora la ferita subita e si trasforma la rabbia in risposta politica, in stretto rapporto con un sindacato che entra in risonanza con questi sentimenti e guida il movimento, senza impossibili briglie, ma con mano sicura. Le richieste sono chiarissime: mettere fuori legge il Msi, epurare dagli apparati dello Stato quanti sono transitati in perfetta continuità dallo Stato fascista a quello repubblicano, rendere obbligatorio lo studio della Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado.
(prosegue nel prossimo numero)