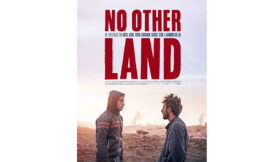Alla fine di gennaio, con la presa da parte dei ribelli del movimento M23 della città di Goma (capitale del Nord Kivu, 800mila abitanti), è tornata momentanemente all’attenzione dell’opinione pubblica l’ultratrentennale guerra nella Repubblica Democratica Congo.
Si tratta di uno dei capitoli più sanguinosi del tragico Risiko tra “filoamericani”, medie potenze europee e, più di recente, cinesi che si gioca in Africa, sempre per interposta persona, finanziando gruppi ribelli e paramilitari.
Nella Repubblica democratica del Congo (111milioni di abitanti su oltre 2,3milioni di kmq) la guerra, tutta per il controllo delle infinite risorse del Paese, dura da tre decenni, con molto più di una decina di milioni di morti e altri milioni di sfollati e profughi. La regione è una delle più instabili e più contese del pianeta. Sono troppi i minerali essenziali, utili a gran parte dei produttori di tecnologia.
Il Movimento 23 marzo (M23) è solo uno dei circa cento gruppi armati che si contendono il territorio e il potere da almeno due decenni. Nel 2012 era già riuscito a conquistare Goma, poi la pressione internazionale lo aveva costretto a ritirarsi. Ora è tornato, forte dell’appoggio del Ruanda, che ovviamente nega ogni coinvolgimento. Ma un rapporto dell’Onu stima che in territorio congolese a fianco dell’M23 potrebbero esserci tra i tremila e i quattromila soldati ruandesi, e i soldati congolesi arresisi ai ribelli a Goma sono stati portati in Ruanda, così come i circa 300 mercenari romeni che affiancavano le forze congolesi, per essere rimpatriati, sono stati condotti a Kigali, capitale del Ruanda.
L’M23 è formato in gran parte da combattenti di etnia tutsi (lo stesso gruppo etnico del presidente ruandese Paul Kagame) e oggi conterebbe circa ottomila combattenti. Dopo una decina d’anni di inattività, quattro anni fa ha ripreso le armi contro il governo del presidente Félix Tshisekedi. Nei territori che man mano è riuscito a conquistare ha cominciato a riscuotere le tasse sull’estrazione dei minerali, in particolare il coltan, e ha messo in piedi un’amministrazione parallela a quella dello stato congolese.
Ma perché il piccolo Rwanda (meno di 12 milioni di abitanti su 26mila Kmq) sostiene i ribelli? Una motivazione potrebbe essere difensiva: per contrastare un’altra milizia, le Forze democratiche di liberazione del Ruanda, gruppo di ribelli attivo nell’est della Rdc, che comprende ancora alcuni dei responsabili del genocidio ruandese del 1994, in cui gli estremisti hutu uccisero circa 800mila tutsi e hutu moderati. Paul Kagame nel 1994 comandava i ribelli tutsi che misero fine ai massacri e considera questa milizia una minaccia esistenziale.
Ma un motivo più plausibile è che l’M23 controlla il contrabbando di minerali preziosi, di cui il Ruanda approfitta vendendoli come propri.
Da tempo, attivisti locali, informazione indipendente e gli stessi missionari italiani denunciano la sostanziale impunità del Ruanda, le responsabilità dell’Europa, la longa manus degli Usa nel “grande gioco” dei minerali “insanguinati” del Nord Kivu. Le immense ricchezze del suolo e sottosuolo sono la ragione che ha favorito la “balcanizzazione” della Rdc, con la popolazione vittima di condizioni come ai tempi di re Leopoldo del Belgio. Tutti hanno approfittato del conflitto predatorio in corso per accedere a oro, cobalto, coltan, rame congolesi, passando attraverso le triangolazioni del Ruanda.
Tanto che l’Unione Europea, a febbraio 2024, ha siglato con il Ruanda, che non possiede miniere sul proprio territorio, un Memorandum of Understandig per lo sviluppo “sostenibile” delle materie prime “critiche”, ossia per aiutare il Ruanda nella raffinazione di oro e tantalio.
“Stranamente” il M23 ha rialzato la cresta proprio a distanza di una settimana dall’insediamento di Trump alla Casa Bianca. La sua nuova presidenza farà di tutto per rilanciare la presenza statunitense in Africa, per contenere l’espansionismo cinese e garantire l’accesso alle materie prime indispensabili all’industria Usa.
Pare certo che Trump andrà avanti con la costruzione del Corridoio di Lobito, arteria ferroviaria cruciale nell’Africa australe. Lunga circa 1.300 chilometri collegherà Zambia settentrionale e Angola, passando per il sud della Rdc e da città come Kolwezi, al centro del business illegale del cobalto. Dal porto di Lobito, attraverso tutta la costa atlantica, una rete finanziata dagli Usa trasporterà materie prime cruciali e terre rare, fondamentali per l’economia occidentale.
Secondo l’analista congolese Dady Saleh, “la svendita totale delle risorse naturali della regione”, dominata non più dalla Cina, ma dagli Stati Uniti.
In quest’ottica si comprende il sostegno dato a diversi “alleati” africani dell’Occidente, come Kagame in Ruanda.
La militarizzazione per procura del continente africano – in un confronto serrato tra Usa e Cina per il controllo delle materie prime – sta ulteriormente radicalizzando i problemi sociali che affliggono l’Africa, condannando gran parte della popolazione a violenze, fame, carestie, lavoro schiavo, esodi biblici.