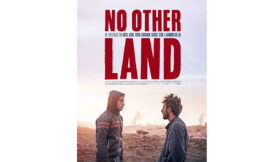Sono innumerevoli gli aspetti della vita e della personalità del compagno Aldo Tortorella. Fine intellettuale, con la sua tesi su Spinoza e la libertà, politica e interiore. Per arrivare a mettere in discussione quel socialismo reale ed egualitario senza libertà, e denunciare le involuzioni di questa democrazia liberale che non applica la Costituzione, con diseguaglianze crescenti.
Giornalista dell’Unità negli anni ‘50. Partecipa insieme a Ingrao alle grandi discussioni sulle contraddizioni del socialismo reale. Poi, da direttore del giornale, descrive un’Italia nuova ed in continuo fermento.
Uomo di partito ma non di apparato, anzi dissacrante e ironico. A cominciare dai suoi anni di segretario del Pci a Milano (1964-1966) quando già guardava oltre, rapportandosi con quei giovani anche in modo conflittuale (come nello scontro Amendola/Ingrao), come Lia Cigarini, Michelangelo Notarianni, per non parlare di Rossana Rossanda, che poi costituiranno il nocciolo de “il manifesto” o della Libreria delle Donne.
Teorico dell’ultimo Berlinguer, con le sue grandi aperture al pacifismo, all’ambientalismo, al femminismo. Nello stesso tempo consapevole dell’importanza di rappresentare e difendere il tuo blocco sociale, anche rischiando la sconfitta.
Tortorella che lascia il Pds-Ds quando intuisce l’impossibilità del condizionamento interno in un partito in piena euforia liberale e sdraiato su una Nato che, dopo l’implosione dell’Urss, anziché sciogliersi si avvia ad assumere il ruolo di gendarme della globalizzazione, che ci porterà al disastro europeo odierno con il ritorno della guerra.
Tortorella che si ritira a riflettere con l’Associazione per il Rinnovamento della Sinistra e “Critica Marxista”. Per altri trent’anni continua a leggere una sinistra in Italia e nel mondo, fornendo analisi per chi non si rassegna, dimostrando che è ancora possibile elaborare innovazione e radicalità.
Negli ultimi anni l’Associazione Berlinguer Milano lo ha incontrato una dozzina di volte nelle proprie iniziative, con almeno 20 ore di registrazioni. Sempre disponibile, mai ortodosso con chiunque fosse interessato a riflettere con lui.
Con questi aspetti della sua vita abbiamo imparato a percorrere l’Italia e il mondo del ‘900 con il Partito Comunista più forte in occidente. Con uno sguardo di parte, non come storici ma come militanti che fanno memoria del passato per comprendere l’oggi.
Insieme a lui abbiamo provato un approccio originale alla storia del Pci. I due anni di grande esaltazione dopo la Resistenza vittoriosa, i risultati importanti delle amministrative del ‘46, la cacciata del re, si concludono con l’approvazione della Costituzione più bella al mondo. Poi la debacle del 18 aprile. Proprio per gli strabilianti risultati istituzionali, il gruppo dirigente del Partito sottovalutò quel vento del nord di quel durissimo dopoguerra. Il mantenimento di forme di democrazia diffusa attraverso i Cln partigiani, l’allargamento dei comitati di gestione nelle fabbriche, con sperimentazioni concrete contro il carovita e per il lavoro, così come per le terre ai contadini, ma soprattutto la mancata epurazione negli apparati pubblici, nell’esercito e nella magistratura.
Aldo chiuse questa discussione con una battuta delle sue: la Germania fece la denazificazione, l’Italia non fece la defascistizzazione.
Una riflessione su come capitalizzare i momenti vincenti, utile nella stagione aperta dal ‘68 studentesco e ‘69 operaio che permisero incredibili conquiste legislative, sindacali e culturali nonostante qualche centinaio di morti voluti dalla strategia delle bombe.
Quando Berlinguer capì che la solidarietà nazionale si stava trasformando in un sistema di potere fece una svolta a 360 gradi, aiutato anche da Aldo, contrario al compromesso storico.
Le fasi di isolamento del Pci non produssero arroccamento settario ma capacità di rinnovamento. La “via italiana al socialismo” con l’ottavo congresso del 1956 segnò l’inizio del distacco dall’Urss; una svolta preparata dall’intero gruppo dirigente con la guida di un prudente Togliatti. Tortorella partecipò a quella discussione da “l’Unità”.
La sua posizione chiara non gli impedì negli anni ‘70 a Milano, segretario di federazione, di valorizzare quei dirigenti operai, come Giuseppe Sacchi, che organizzarono le lotte operaie ante ‘69 e si opposero alla svolta.
Aldo ci descriveva la difficile stagione dell’ultimo Berlinguer, quando gli capitava di rimanere in minoranza nel gruppo dirigente, ma intoccabile per il fortissimo consenso in quella grande comunità che fu il Pci.
In uno degli ultimi incontri a febbraio 2024, ebbe modo di dirci che quell’orgoglio comunista tanto criticato era la risposta a un sistema dei partiti ormai marcio; senza quella denuncia non saremmo stati credibili nella difesa del nostro blocco sociale e nemmeno nell’apertura ai nuovi movimenti. Ecco perché la risposta referendaria all’attacco alla scala mobile.